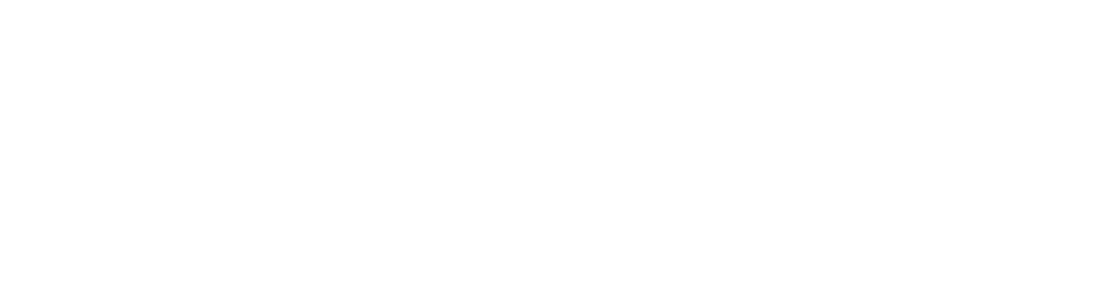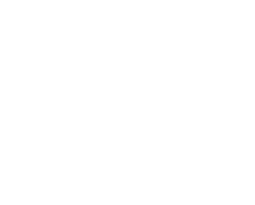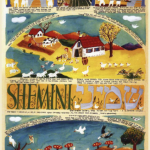Cibo per la mente – Parshat Shemini
di Rabbino Lord Jonathan Sacks zt”l
tradotto ed adattato da David Malamut
La seconda metà del Libro dell’ Esodo e la prima parte del Levitico formano una narrazione attentamente strutturata. Agli Israeliti viene comandato di costruire un Santuario. Eseguono il comando. Segue il resoconto dei sacrifici che vi saranno offerti. Poi, nella prima parte della Parasha di questa settimana, i Kohanim – i Sacerdoti – vengono insediati al loro incarico.
Quello che succede dopo, però, è inaspettato: vengono presentate le leggi alimentari, un elenco di specie, animali, pesci e uccelli permessi e proibiti. Qual è la logica di queste leggi? E perché sono inserite proprio qui? Qual è il loro collegamento con il Santuario?
Il noto Rabbino Elie Munk aveva proposto un’affascinante ipotesi come risposta (Elie Munk, The Call of the Torah, vol. 2, p. 99). Come è stato già accennato negli studi passati, il Santuario era la controparte umana del cosmo. Diverse parole chiave nel racconto biblico della sua costruzione sono anche parole chiave nella narrazione della creazione all’inizio della Genesi. Il Talmud (Megillah 10b) dice, a proposito del completamento del Santuario, che “In quel giorno ci fu gioia davanti al Santo, benedetto Egli sia, come nel giorno in cui furono creati il Cielo e la Terra”. L’universo è la casa che Dio ha creato per l’umanità. Il Santuario era la casa che gli esseri umani hanno creato per Dio“.
Rabbino Munk ci ricorda che il primo comandamento che Dio diede al primo essere umano fu una legge alimentare. “Sei libero di mangiare di qualsiasi albero del giardino; ma non devi mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male, perché quando ne mangerai, sicuramente morirai“. Le leggi alimentari nella parsha di Shemini sono parallele al divieto imposto a Adamo. Come allora, così ora, una nuova era si presentò nella storia spirituale dell’umanità, preceduta da un atto di creazione, e segnata da leggi su ciò che si può e non si può mangiare.
Perché? Come per il sesso, così per il mangiare: queste sono le attività più primordiali, condivise con molte altre forme di vita. Senza sesso non c’è continuazione della specie. Senza cibo, nemmeno l’individuo può sopravvivere. Queste, quindi, sono state al centro di culture radicalmente diverse. Da un lato ci sono culture edonistiche in cui cibo e sesso sono visti come piaceri e perseguiti come tali. Dall’altro ci sono culture ascetiche, caratterizzate dalla clausura monastica, in cui il sesso viene evitato e il mangiare ridotto al minimo. Le prime enfatizzano il corpo, le seconde l’anima. L’ebraismo, al contrario, vede la condizione umana in termini di integrazione ed equilibrio. Siamo corpo e anima. Da qui l’imperativo giudaico, né edonistico né ascetico, ma trasformativo. Ci viene comandato di santificare le attività del mangiare e del sesso. Da questo scaturiscono le leggi alimentari e le leggi della purezza familiare (niddah e mikveh), due elementi chiave della kedushah, la vita di santità.
Tuttavia, possiamo andare oltre. Il primo capitolo della Genesi non è l’unico racconto della Creazione nel Tanach, la Bibbia ebraica. Ce ne sono diversi altri. Uno è contenuto negli ultimi capitoli del Libro di Giobbe. È questo che merita particolare attenzione.
Giobbe è il paradigma del giusto che soffre. Perde tutto ciò che ha, senza apparente motivo. I suoi compagni gli dicono che deve aver peccato. Solo questo può conciliare il suo destino con la giustizia. Giobbe si proclama innocente e chiede di essere ascoltato nel tribunale celeste. Per circa 37 capitoli la discussione diventa accesa, poi nel capitolo 38 Dio si rivolge a Giobbe “dal turbine” (מִן הַסְּעָרָה). Dio non offre risposte. Addirittura di contro, per quattro capitoli, pone domande proprie, domande retoriche che non hanno risposta:
“Dov’eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra?… Hai forse viaggiato fino alle sorgenti del mare o camminato nei recessi dell’abisso?… Ha forse la pioggia un padre?… Dal grembo di chi esce il ghiaccio?”
Dio mostra a Giobbe l’intera gamma della creazione, ma si tratta di una visione dell’universo molto diversa da quella esposta in Genesi 1-2. Lì il centro della narrazione è la persona umana, ed è l’ultima ad essere creata; è fatta a immagine di Dio; a cui è stato dato il dominio su tutto ciò che vive. Nel Libro di Giobbe 38-41 non vediamo un universo antropocentrico, ma teocentrico. Giobbe è l’unica persona nel Tanach che vede il mondo, per così dire, dal punto di vista di Dio.
Particolarmente sorprendente è il modo in cui questi capitoli trattano il regno animale. Ciò che Giobbe vede non sono animali domestici, ma creature selvagge e indomabili, magnifiche nella loro forza e bellezza, che vivono lontane e totalmente indifferenti al genere umano:
“Dai forse al cavallo la sua forza o gli rivesti il collo di una fluente criniera?
Lo fai forse balzare come una locusta, incutendo terrore con il suo fiero sbuffare?…
Forse il falco spicca il volo con la tua saggezza e spiega le ali verso sud?
L’aquila si libra al tuo comando e costruisce il suo nido in alto?…
Puoi forse tirare il leviatano con un amo da pesca o legargli la lingua con una corda?
Puoi infilargli una corda nel naso o trafiggergli la mascella con un uncino?…
Nulla sulla Terra è uguale a Lui: una creatura senza paura.
Guarda dall’alto in basso tutti gli altezzosi;
È Re di tutti i superbi.”
Questo è il brano più radicalmente non antropocentrico della Bibbia ebraica. Ci dice che l’uomo non è il centro dell’universo, né siamo la misura di tutte le cose. Alcuni degli aspetti più gloriosi della natura non hanno nulla a che fare con i bisogni umani, ma con la creazione divina della diversità. Uno dei pochi pensatori ebrei ad affermarlo chiaramente fu Mosè Maimonide nella sua opera La guida dei Perplessi:
“Considero la seguente opinione la più corretta, secondo l’insegnamento della Bibbia e i risultati della filosofia: l’universo non esiste per l’uomo, ma ogni essere esiste per sé stesso, e non per qualche altra cosa. Pertanto, crediamo nella Creazione, e tuttavia non abbiamo bisogno di chiederci a quale scopo serva ciascuna specie di cose esistenti, perché presumiamo che Dio abbia creato tutte le parti dell’universo per Sua volontà; alcune per se stesse, e altre per altri esseri…
La guida dei Perplessi, III:13”
E ancora:
“Considerate quanto vaste siano le dimensioni e quanto grande sia il numero di questi esseri corporei. Se l’intera Terra non costituisce neppure la più piccola parte della sfera delle stelle fisse, qual è la relazione della specie umana con tutte queste cose create, e come può qualcuno di noi immaginare che esistano per lui e che siano strumenti a suo beneficio?
La guida dei Perplessi, III:14”
Ora comprendiamo la posta in gioco nel divieto di alcune specie di animali, uccelli e pesci, molti dei quali predatori come le creature descritte in Giobbe 38-41. Esistono per il loro bene, non per il bene dell’umanità. Il vasto universo, e la Terra stessa con le miriadi di specie che contiene, hanno una propria integrità. Sì, dopo il Diluvio, Dio diede agli esseri umani il permesso di mangiare carne, ma questa fu una concessione, come a dire: Uccidi se devi, ma lascia che siano gli animali, non gli altri esseri umani, a uccidere.
Con la Sua alleanza con gli Israeliti, Dio invita l’umanità a iniziare un nuovo capitolo della storia. Questo non è ancora il Giardino dell’Eden, il paradiso riconquistato. Ma, con la costruzione del Santuario, cioè una dimora simbolica per la presenza divina sulla Terra, qualcosa di nuovo è iniziato. Un segno di ciò è il fatto che agli Israeliti non è permesso uccidere alcuna forma di vita per nutrirsi. Alcune specie devono essere protette, devono essere loro concesse la libertà, la loro integrità, lasciate indifese rispetto ai desideri e agli artifici umani.
La nuova creazione, il Santuario, segna una nuova dignità per la vecchia creazione, in particolare per le sue creature selvagge e indomabili. Non tutto nell’universo è stato creato per il consumo umano.